Approfondimento sulla riforma della Giustizia Tributaria
- Home
- Approfondimenti
- Riforma della Giustizia Tributaria
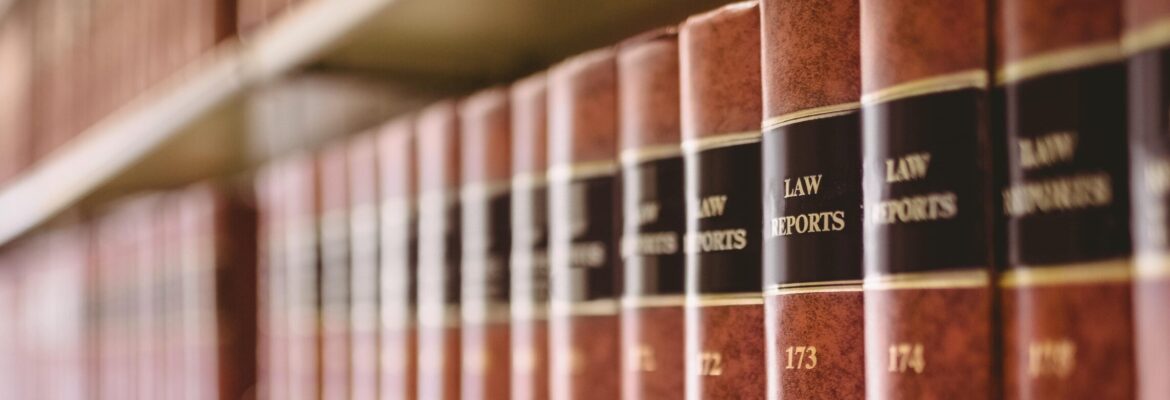
Posted Mar 2023
- 0 comment
- 0
RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
(Legge del 31 agosto n. 130/2022 – entrata in vigore il 16 settembre 2022)
*****
A cura di: Salvatore Lacopo
1. Corte di Giustizia Tributaria e Giudice Tributario:
Innanzitutto, la riforma interviene sulla denominazione. Si passa, infatti, da Commissione tributaria provinciale a Corte di Giustizia tributaria di 1° grado e da Commissione tributaria regionale a Corte di Giustizia tributaria di 2° grado.
Inoltre, il Giudice tributario non sarà più nominato, bensì verrà designato allo svolgimento delle sue funzioni a seguito del superamento di un pubblico concorso. Seppur il testo originario della disciplina ammetteva a tale concorso soltanto i laureati in giurisprudenza, oggi vi è un’apertura anche a coloro i quali hanno ricevuto una formazione in ambito economico (laurea magistrale in scienze dell’economia – LM56 o scienze economico-aziendali – LM77).
2. Udienze da remoto:
Per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2023 si prevedono nuove regole per le udienze a distanza.
Infatti, giudici e personale amministrativo potranno operare da remoto. Nessun obbligo di notificare alle parti costituite l’istanza di udienza a distanza, che sarà invece depositata entro il termine per il deposito dei documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione). La richiesta di trattazione a distanza dovrà essere formulata da tutte la parti costituite nel processo. Diversamente si applicherà la disciplina dell’udienza presso la sede delle Corti di Giustizia Tributaria.
Si svolgeranno esclusivamente a distanza le pubbliche udienze della Corte in primo grado in composizione monocratica e quelle di trattazione dell’istanza cautelare, salva la possibilità per ciascuna parte di chiedere la partecipazione in presenza all’udienza.
3. Art. 4-bis D.Lgs. n. 546 del 1992:
La novella del 2022 introduce l’art. 4-bis, D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale tutte le controversie di valore fino a 3.000 Euro sono decise dalle Corti di Giustizia tributaria di 1° grado in composizione monocratica anziché in composizione collegiale.
Per valore della controversia si intende l’imposta pura al netto delle sanzioni e degli interessi (art. 12, comma 2). Disposizione che non trova applicazione per le controversie con valore indeterminabile!
Resta ferma l’applicazione di tutte le disposizioni applicabili ai giudizi tributari in composizione collegiale.
Detta disposizione è applicabile a tutti i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023.
La ratio dell’introduzione del giudice monocratico è quella di voler distinguere le controversie di modico valore da quelle complesse.
4. art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992:
Prima della riforma del 2022, accadeva che, se con l’impugnazione dell’atto (avviso di accertamento immediatamente esecutivo/cartella esattoriale) si presentava formale istanza per la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, al fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate/Riscossione desse vita a una serie di atti esecutivi, la relativa udienza preliminare (per l’esame della sospensione) veniva fissata non prima di 180 giorni dall’istanza di sospensione – istanza che, si rammenta, deve essere motivata soprattutto in punto di periculum in mora per bene dimostrare una preesistente situazione economica deficitaria -.
Questo “lungo termine” non faceva altro che vanificare la ratio dell’istituto della tutela precautelare.
Pertanto, la novella del 2022 interviene proprio per meglio valorizzare tale istituto e lo fa introducendo al comma 2 dell’art. 47 un diverso termine perentorio: “il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, (…)”. Quindi, non più entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza!
Inoltre, viene abrogato il comma 5-bis dell’art. 47 (l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa).
5. Art. 48-bis D.Lgs. n. 546 del 1992:
Altra importante novità è la possibilità per la Corte di Giustizia tributaria, ai sensi dell’art. 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992, per le controversie soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis (controversie di valore non superiore a cinquantamila euro), di formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
Questa proposta può essere formulata sia in udienza che fuori. Se non si perfeziona l’accordo conciliativo, viene fissata l’udienza di trattazione; in caso contrario, viene redatto il processo verbale e verrà formalizzata la cessazione della materia del contendere.
La ratio è quella di definire la questione prima che si “arrivi a sentenza”.
Nel caso di mancata accettazione senza giustificato motivo della proposta conciliativa (proposta tanto dalla parte quanto dal giudice), ai sensi dell’art. 15, comma 2-octies, sono poste a carico di chi rinuncia le spese di giudizio maggiorate del 50% ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta a essa effettuata. Se è intervenuta la conciliazione le spese sono compensate, salvo diverso accordo convenuto dalle parti nel processo verbale di conciliazione.
6. Art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992:
-comma 4:
Si prevede per la prima volta l’utilizzo della prova testimoniale nel giudizio tributario.
Infatti, la Corte di Giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale assunta nelle forme di cui all’art. 257-bis c.p.c..
Quanto alle modalità, la parte predisporrà un “modello di testimonianza” (trattandosi di una prova documentale) che verrà compilato e sottoscritto dal teste e, successivamente, depositato in cancelleria entro il limite intimato.
Tale prova potrà essere richiesta in Appello se non è stato possibile richiederla in 1° grado per cause non imputabili.
L’unico limite che incontra tale prova riguarda i verbali o gli atti che fanno fede fino a querela di falso posti a fondamento della pretesa tributaria, dove la prova sarà ammessa solo per i fatti diversi da quelli attestati dal pubblico ufficiale.
Tale comma 4, avrà applicazione per i ricorsi aventi data successiva all’entrata in vigore della legge 130/2022 (16 settembre 2022).
– comma 5-bis:
Al fine di evitare l’annullamento dell’atto impositivo, l’Amministrazione finanziaria, non solo ha l’onere di cui all’art. 2697, comma 1, c.c. (l’ufficio dovrà provare i presupposti di fatto), ma gli elementi di prova dovranno rispettare la nuova disposizione del comma 5-bis e, quindi, essere:
- inerenti rispetto ai fatti costitutivi;
- sufficienti a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa;
- coerenti con la normativa tributaria sostanziale.
Di conseguenza, un onera di prova più stringente per l’Amministrazione finanziaria.
Sul contribuente resta sempre l’onere della prova contraria.
6. Art. 5, comma 1 e 2, Legge 130 del 2022:
> definibili con il pagamento del 5% del valore della lite (imposta):
- viene introdotta la possibilità di definire le liti che al 15 luglio 2022 risultano pendenti in Cassazione o comunque introdotte non oltre il 16 settembre 2022;
- alla data di presentazione della domanda non è intervenuta sentenza definitiva;
- è necessario che l’amministrazione finanziaria sia ricorrente in Cassazione in quanto soccombente in entrambi i gradi di giudizio (doppia conforme);
- deve trattarsi di lite con valore non superiore a 100mila Euro.
> definibili con il pagamento del 20% del valore della lite:
salvo quanto sopra (pendenza al 15.07.2022/introdotte il 16.09.2022; nessuna sentenza definitiva)
- se vi è soccombenza dell’amministrazione tributaria in un solo grado di merito;
- lite con valore non superiore a 50mila Euro.